Nell’ultimo mese, mi son fatta frequenti capatine sulle bacheche di parecchi amici scrittori. Gente che in buona parte stimo e che – proprio per questo motivo – mi ha colpito per l’atteggiamento tenuto rispetto alla serie che si è conclusa ieri sera. Parlo di Game of Thrones, ovviamente.
In linea di massima, la reazione si può dividere in tre grandi categorie: quella di chi dichiara (con orgoglio) di non aver visto la serie, quella di chi chi ammette (coi denti davanti) di averla vista in parte e di trovarla pessima e quella di chi tace. La cosa che trovo strana – visto che apparentemente non stiamo parlando di una setta, ma di intellettuali presumibilmente liberi – è la povertà di voci fuori dal coro. Autori, cioè, che dichiarino che a loro, GoT, è piaciuto. Ovviamente parlo di un campione di persone piuttosto ristretto e circoscritto agli autori con cui sono in contatto sui social… di fatto, però, la domanda mi sorge spontanea: a che pro, tanto aristocratico snobismo?
Personalmente, mi è piaciuta tanto la serie quanto il suo discusso (ma poteva essere altrimenti?) finale. Al di là di questo, però, vorrei spostare l’attenzione su un altro campo: quello della percezione. E anche quello dell’utilità di GoT in termini di storytelling, per chi – di lavoro – costruisce storie.

La vitalità delle serie televisive vista da un altro punto di vista
La gente legge di meno, è un dato di fatto, ma il successo di alcune serie televisive – GoT in primis – potrebbe secondo me aiutarci a guardare al problema in un’altra prospettiva. Leggiamo di meno ma, di contro, non abbiamo smesso di aver bisogno di storie. C’è gente che si tappa in casa per fagocitare serie televisive, gente che cade nella dipendenza, altri che sviluppano un vero e proprio fanatismo.
Si può storcere il naso e parlare di fenomeni pop e di massa, ma questo non cambia il nocciolo della questione: oggi, come e forse più di ieri, continuiamo ad avere bisogno di storie e il fatto che il libro (come supporto di queste storie) stia in parte perdendo terreno è un problema, sì, ma non un’apocalisse. I libri non sono sempre esistiti, le storie sì. E a guardarle con occhi nuovi, sembrano avere una resilienza e una vitalità fuori dal comune.
Considerando le cose in quest’ottica, secondo me, il vero problema – il vero nemico – non è il fatto che la gente legga di meno ma qualcosa di molto più grave. Parlo del dilagare dell’analfabetismo funzionale e di quel deficit di attenzione che miete vittime tra i più giovani (ma anche tra di noi). il problema non è chi non legge, ma l’atteggiamento abulico e i neuroni in pappa di chi non riesce più a seguire il filo di una storia. Quindi, viva le serie televisive se – almeno per ora – aiutano a controbilanciare quella che, sì!, sarebbe un’apocalisse!

Qual è la forza di Game of Thrones come storia? E cosa può lasciare di utile, a chi scrive?
Proprio perché ci troviamo davanti a una storia che funziona e che smonta parecchi cliché dati per assodati nello storytelling tradizionale, la risposta non è univoca. Per quanto mi riguarda, sottolineerei il “cambio di domanda” che riguarda l’Eroe. Cosa sia il Viaggio dell’Eroe, lo sa chiunque si sia masticato un po’di morfologia della fiaba. Ci sono serie televisive, che hanno gonfiato e moltiplicato le domande sul tema. “Fortitude”, per esempio – prima di mandare tutto in vacca nelle due stagioni successive – ha amplificato l’interrogativo “Chi è l’Eroe?” sullo sfondo di un contesto che avrebbe fatto vedere i sorci verdi anche all’Agatha Christie di “Dieci piccoli indiani”.
Game of Thrones fa qualcosa di diverso: moltiplica le domande o meglio, le frammenta e le accorpa intorno a quello che secondo me è il grande nucleo centrale. Non “chi è l’Eroe?” ma: “cos’è che rende tale un Eroe?” A modo suo, penso che ogni personaggio sia una risposta a questa domanda, che non presuppone (e alla fine non dà) una risposta univoca. Per il semplice fatto che una risposta esterna, non c’è. L’Altrove, è quell’azzurro apparente – che ci protegge da una Notte assoluta – di cui parla Paul Bowles in “Un tè nel deserto”. Gli Dei si manifestano in un alfabeto che i maghi non sanno decifrare e in nome del quale compiono ecatombi senza senso (vedi Melisandre).
In questa assoluta mancanza di un referente esterno (o meglio: di una trascendenza intellegibile) le “anime belle” – tipo Ned Stark – in fondo non servono a nessuno. Brienne di Tarth – epigono del cavaliere senza macchia e senza paura – è un Don Chisciotte triste, che si aggrappa a un giuramento e all’idea di una missione come se si trattasse di un suo personale esorcismo contro il Buio. Lo stesso stato di indecisione cronica a cui è crocifisso Jon Snow, allude a questa difficoltà normativa di trovare un principio etico universale a cui aggrapparsi.
Il discrimine tra i personaggi sta proprio qui: qualcuno di loro è nato con dentro un daimon da seguire, altri cercano ancora questa voce all’esterno. E non la trovano. Arya sa già chi è (e chi non è: cioè una lady) già dalla prima serie e una volta dismesso il vessillo della vendetta (la “sua” personale missione cavalleresca, quasi un doppio specularmente opposto a quello di Brienne) seguirà il suo daimon in composta solitudine. Danerys ha pure lei il suo daimon… solo che, nella sua parabola napoleonica, gli mette in mano un megafono e una missione ecumenica che trascineranno lei (e mezzo mondo) in un gigantesco tritacarne. Ecco, io credo che sia questa la chiave dell’originalità (e della bellezza) di Game of Thrones in termini di storytelling: la frammentazione dell’Eroe – inteso come monolite – in una nebulosa di schegge apparentemente impazzite ma che seguono ognuna, la sua precisa traiettoria. E’ questo che genera i colpi di scena davvero imprevedibili, che sbaraglia le carte in tavola alla Sequenza di Propp e che dà l’impressione – a chi segue la storia – di essere davanti a qualcosa di completamente nuovo.
Game of Thrones ha cambiato il nostro sguardo sulle storie. Fenomeno pop? Forse, ma girare la testa dall’altra parte non ci rende più aristocratici: ci rende solo più miopi.



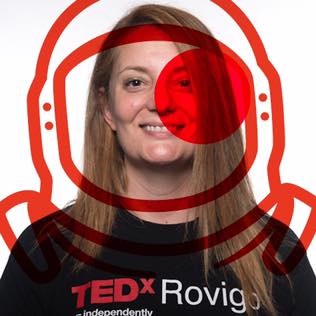





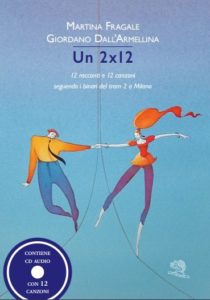 Tutto è cominciato così: con me e
Tutto è cominciato così: con me e 



