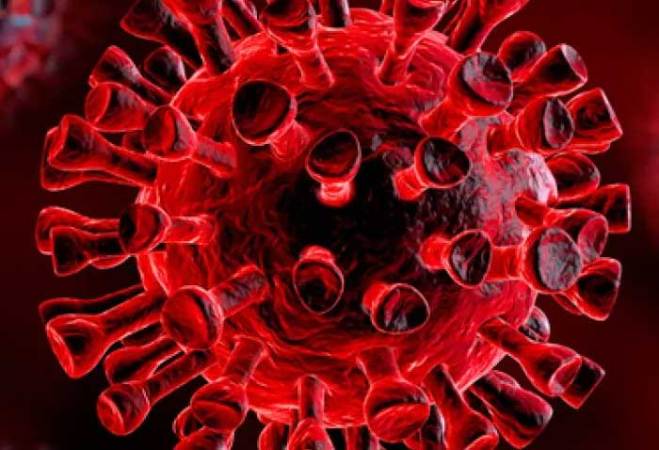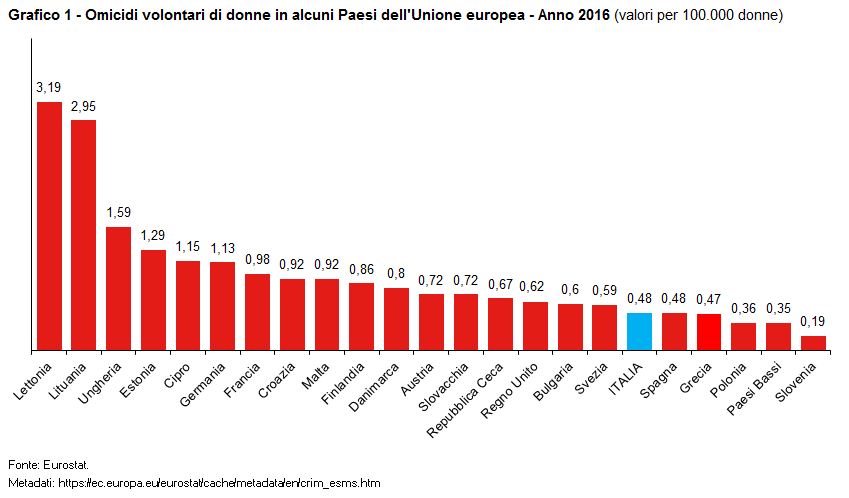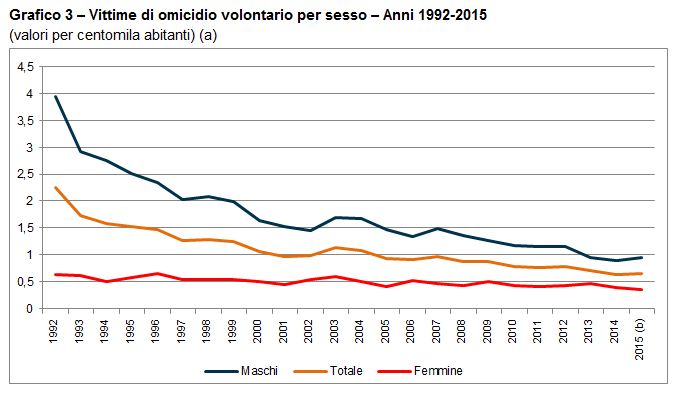La gestione del covid non è solo un problema che riguarda il reparto malattie infettive. Anche un paziente oncologico, senza contrarre il covid-19, può morire a causa non del virus ma della gestione che ne è stata fatta. Così come un chirurgo che lavora in ambito oncologico, rischia di non poter fare il proprio lavoro, andando incontro a gravi conseguenze. In questa intervista, X – chirurgo che opera in un grande ospedale pubblico lombardo e che ha principalmente a che fare con pazienti oncologici – racconta quali conseguenze ha avuto la gestione del virus sul suo settore e sul suo lavoro. L’intervista è “clandestina” perché la Direzione del noto ospedale lombardo di cui si parla, ha vietato ai suoi dipendenti qualsiasi dichiarazione pubblica. Nelle intenzioni di X, l’intervista non rappresenta una denuncia fine a se stessa, quanto piuttosto un tentativo di mettere a fuoco una serie di problematiche a cui sarà necessario (e urgente) trovare delle soluzioni.
Qual è stato l’impatto della situazione covid su un reparto come il tuo, diciamo, “periferico”: in cui medici, cioè, lavorano con altre tipologie di pazienti, che non sono covid-positivi? Cosa hai visto cambiare?
Tutto, dalla A alla Z. Ogni singolo aspetto della nostra attività è stato completamente stravolto. Sostanzialmente siamo andati incontro a un progressivo lockdown anche noi. Ti parlo innanzitutto di cambiamenti quantitativi. Conta, per esempio che di solito operiamo circa 25 pazienti alla settimana (quindi 100 persone al mese, di cui 80 sono malati oncologici) mentre nell’ultimo mese abbiamo operato 6 pazienti di cui 5 tumorali gravissimi.
E gli altri?
Tutti gli altri sono rimasti in attesa. Non parlo solo di sala operatoria ma anche di attività di reparto. Normalmente abbiamo X posti letto che nell’ultimo mese sono andati riducendosi progressivamente per poter accogliere i pazienti covid-positivi. Cosa che abbiamo ovviamente accettato come indispensabile perché è chiaro che c’era (e c’è) un’urgenza più immediata.
Parliamo quindi di impatto sia sui pazienti oncologici che su altre tipologie di pazienti.
Sì. Da noi abbiamo un’attività di sala operatoria – e di conseguenza la necessità di posti letto – e un’attività ambulatoriale (in day hospital) dove effettuiamo piccole manovre parzialmente invasive, non proprio chirurgiche ma comunque non differibili.
Per esempio?
Ad esempio, procedure invasive cui i pazienti devono sottoporsi periodicamente, pena complicanze come le infezioni. E di setticemia, si muore. In pratica, così come per le attività chirurgiche, anche da questo punto di vista abbiamo dovuto limitare al massimo l’uso dei posti letto.
Cosa ha implicato questo, per voi e per il paziente? Un calo degli interventi?
No. Gli interventi minori come le suddette procedure, abbiamo continuato a garantirli ugualmente ma gestendoli a livello esclusivamente ambulatoriale, praticamente rimandando i pazienti a casa subito dopo a costo di rischiare sulla loro pelle e sulla nostra professionalità, proprio perché si tratta di procedure non procrastinabili.
Cosa rischia un medico costretto ad adottare questo modus operandi?
Rischia di non essere tutelato in nessun modo: un paziente, per esempio, potrebbe tranquillamente trascinarlo in tribunale (il che, come sai, è già una pratica molto diffusa in Italia negli ultimi anni). Oltre al rischio, in primis, di nuocere al paziente.
Tutto questo, ovviamente, abbiamo cercato di farlo passare attraverso la Direzione, in modo da avere (diciamo) un avallo esplicito da parte dell’ospedale.
E…?
Il sì è arrivato ma solo a parole, senza nulla di scritto. In pratica è come se stessimo utilizzando dei protocolli di guerra senza che però nessuno ce ne abbia dato esplicitamente uno. Le risposte arrivano in maniera del tutto informale, via mail o tramite whatsapp: quindi senza nessuna reale tutela, per noi.
Le grandi riorganizzazioni dell’attività sono state formalizzate, ma per le singole procedure della quotidianità abbiamo avuto un adattamento darwiniano non riconosciuto formalmente e che pertanto libera la Direzione da ogni responsabilità futura.Come si dice…”aiutati che Dio ti aiuta”.
Questo, a livello di gestione interna. Sul piano invece della gestione esterna, come si è attivata la Regione?
Quando è diventato palese a tutti che i tempi dell’epidemia sarebbero stati lunghi e di conseguenza il blocco dell’attività ordinaria non urgente, la Regione ha creato una rete assistenziale che comprendesse anche la sanità privata e quella privata convenzionata, per dare respiro a quella pubblica ormai al collasso. Cosa che porta alla ribalta un altro tema (quello del rapporto tra pubblico e privato) su cui vale la pena di riflettere.
Mi dicevi che questo vi consente comunque di operare solo una parte dei vostri pazienti.
Sì, sulle nostre liste di attesa per patologie oncologiche (già abitualmente lunghe e ben oltre i trenta giorni entro i quali per legge bisognerebbe garantire le cure ad un paziente oncologico) siamo stati costretti a fare una forte selezione. Ti assicuro che questo è stato uno dei momenti più difficili: una sorta di “tu sì, tu no”, ben sapendo che chi non è stato classificato come urgente lo diventerà presto. Per un medico, dover dire a un paziente “non posso aiutarti” è qualcosa di terribile.
Cioè avete dovuto scegliere chi operare o meno?
Sì, sapendo peraltro che avremmo potuto curare anche meno pazienti di quanto ipotizzato.
E in base a quali direttive viene operata la selezione?
C’è tutto un dibattito sulle linee guida SIAARTI (Società Italiana di Anestesia, Analgesia, Rianimazione e Terapia Intensiva) secondo cui, in un momento di disponibilità insufficienti, bisogna cercare di privilegiare le risorse e darle a chi ha maggiori aspettative di vita. Questo in realtà non riguarda solo gli anestesisti ma anche noi. La notizia di oggi, per esempio, è che un paziente che era da 4 mesi in lista di attesa per un tumore, che era candidato a un intervento molto demolitivo e che – essendo un paziente fragile – aveva bisogno di un posto in terapia intensiva (per cui continuava a essere rinviato a causa della saturazione delle terapie intensive), ha fatto una rivalutazione da cui è risultato che sono insorte delle metastasi. Questo significa che quel paziente non verrà più operato, perché ormai la chirurgia non sarebbe più curativa per lui. Sarà un morto di tumore in più che forse, chissà, magari con un’operazione più tempestiva, si sarebbe salvato.
Come fate a comunicare a un paziente come questo che non lo potete operare? Vi sono state date delle linee guida generali?
Abbiamo avuto un mese di “pausa”, o quantomeno di riorganizzazione dell’attività come dopo un terremoto, e in questo lasso di tempo il grosso dell’attività è stato rispondere alle chiamate dei pazienti che ci chiedevano “Allora, quand’è che mi operate?” C’è stato quindi, di fatto, un contatto costante.
Guidato dalla direzione dell’ospedale?
No, assolutamente autogestito. In totale assenza di direttive. Abbiamo cercato di gestire tutto al meglio, in scienza e coscienza.
A livello di comunicazione, quindi, l’unica direttiva che avete ricevuto è l’obbligo di non comunicare all’esterno nulla di ciò che sta succedendo nel vostro ospedale?
Esatto.
E quando vi è stata comunicata?
Subito all’inizio, ribadita poi ulteriormente quando un dipendente ha inviato un messaggio whatsapp, in cui diceva peraltro cose verissime e che puntualmente si sono verificate e il vocal è diventato virale. Tant’è che a distanza di poche ore ci è arrivata la seconda comunicazione per cui l’unica deputata a dare informazioni è la Direzione, tramite le indicazioni della Regione.
Si è trattato di una direttiva interna, quindi? Non regionale?
Ufficialmente, la direttiva è arrivata dalla Regione. Nel nostro ospedale ci sono circa X (centinaia, ndr) malati covid ricoverati, su X (più che centinaia, ndr) posti letto. Ne sapevi qualcosa? Ne hai sentito parlare? Sicuramente no, tutt’oggi dopo più di un mese la gente continua ancora a chiedermi “ma da voi ci sono pazienti covid?”. Quando si parla di ospedali in prima linea per l’emergenza covid vengono nominati il Sacco, il San Raffaele. Non si parla di noi. La situazione è stata gestita in modo tale da evitare che uscissero informazioni da qui. Tanto che mentre venivano diffuse le linee guida di SIAARTI, che stabilivano la necessità di suddividere equamente le risorse, mentre a Bergamo il primario della rianimazione dichiarava apertamente che loro non potevano dare risorse a tutti perché le risorse le avevano finite, da noi si dichiarava pubblicamente che non è vero che il nostro ospedale non ha risorse e che i pazienti vengono selezionati ma che, al contrario, anche un ottantenne qui ha la possibilità di venire intubato come tutti gli altri pazienti. Si tratta di dichiarazioni ufficiali facilmente rintracciabili sui media, se vuoi verificare. Bè, io ho qui ricoverato un amico sulla settantina, che per fortuna non ha bisogno di essere intubato. Nel caso, so che i colleghi non me lo negherebbero e la cosa quasi mi dispiace, perché so che non può essere per tutti così.
Anche in altri ospedali, comunque ho dovuto rinunciare a intervistare il personale per direttive che (in quei casi, esplicitamente) venivano dalla Regione.
Non stento a crederlo. Sicuramente la direttiva originaria viene dalla Regione che vuole mantenere il controllo dei dati. Sappiamo bene, infatti, che il numero dei morti, dei contagi e dei malati è falsato da una serie di fattori infinita.
Ti riferisci alla scarsità di tamponi effettuati, immagino.
Sì, per quanto riguarda i contagi ma non solo. Prendiamo il numero dei deceduti: ce ne sono centinaia, che sono morti nella propria casa… in teoria di polmonite ma di fatto senza che nessuno li abbia sottoposti a tampone (e che quindi non rientrano nelle statistiche). Idem per quanto riguarda i malati che – finché non li sottoponi a tampone – non risultano percentualmente fra i malati di covid. La stessa cosa vale per i contagi, in merito agli asintomatici che hanno contratto il virus. Qui per esempio, non sappiamo chi fra di noi è stato contagiato perché la Regione Lombardia ha deciso di non fare tamponi a tappeto e i sanitari vengono sottoposti a tampone solo alla guarigione.
Non nel momento in cui insorgono dei sintomi?
No: non c’è il tampone alla diagnosi, ma al rientro. Dopo i classici 14 giorni viene effettuato un tampone, seguito – a un giorno di distanza – da un altro tampone. Con due tamponi negativi, puoi rientrare in servizio.
Questo, quindi, se sei sintomatico.
… e se sei in Lombardia. I nostri colleghi in Veneto vengono sottoposti a un trattamento ben diverso. Ho colleghi di Padova, Verona e Bassano che mi dicono che hanno già fatto 4 tamponi a testa. Cioè, in pratica, un tampone alla settimana. Anche i pazienti hanno un trattamento diverso. Nel loro ospedale non entra un paziente che non sia già stato sottoposto a tampone: ti parlo sia di pazienti arrivati al Pronto Soccorso, sia di pazienti che arrivano per interventi di qualsiasi tipo non procrastinabili. Queste sono differenze che hanno un peso enorme. Non te lo dico pensando solo ai medici ma anche e soprattutto nell’interesse dei pazienti: è un dato di fatto, noi medici siamo il principale veicolo di diffusione del virus. Veicolo interno ed esterno. Considera che siamo in pieno lockdown: praticamente, gli unici che girano a piede libero, siamo noi sanitari.
Visto quindi che regioni diverse hanno adottato una politica sui tamponi differente, perché secondo te Regione Lombardia ha preso questa strada?
Io ho la mia idea. Credo che la Lombardia abbia sbagliato direzione all’inizio. Quando uno fa un errore madornale in prima battuta e questo errore causa una catastrofe, poi dire “scusate, abbiamo sbagliato: ora cambiamo direzione” implica un suicidio politico. È così, quindi, che continua a venir iterato lo stesso errore che provoca morti su morti, per un unico motivo.
Senza stare a piangere sul latte versato, quale potrebbe essere l’alternativa, in questo momento? Perché immagino che un’alternativa ci sia.
Certo che c’è. Soprattutto ora, che i contagi sono stazionari e l’emergenza è più contenuta. È questo il momento di agire: di sterilizzare gli ospedali e di fare in modo che medici, infermieri, OSS e tutti quanti, siano sottoposti a tampone in modo da non reiterare la diffusione del virus. Siamo in un momento cruciale in cui davvero, si potrebbe cambiare strada.
E perché non viene fatto?
Probabilmente per paura di trovare troppi sanitari covid-positivi e di vedersi svuotare gli ospedali.
È un timore giustificato, secondo te?
No. Perché anche nell’ipotesi in cui io – asintomatico – risulti positivo, potrò comunque in tutta serenità andare a lavorare nel reparto destinato ai pazienti covid-positivi: evitando, quindi, di infettare gli altri ma rimanendo allo stesso tempo attivo.
Parliamo dei presidi. Quali sono le principali carenze che avete notato?
Le carenze sono a tutti i livelli. C’è il livello di sicurezza estrema, di cui si dovrebbe avere bisogno nei reparti di terapia intensiva dove i pazienti covid vengono intubati e dove c’è il rischio concreto di aerosolizzazione del virus (le famose droplets). Le prime rianimazioni sono partite perfettamente equipaggiate di tute in tyvek, poi progressivamente – venendo meno le tute – ci si è basati su altri presidi, che però sono inadeguati. Una collega mi ha parlato di visiere che, pur essendo un dispositivo monouso per definizione, vengono tenute per giorni interi, lavate con alcool a fine turno e debitamente conservate per evitare che vengano trafugate essendo diventate merce preziosa. Alla fine sono così usurate che, proprio nel momento dell’intubazione (il più rischioso, quindi) vengono direttamente tolte. Stessa cosa per quanto riguarda le mascherine ffp3, che vengono tenute ben oltre il loro limite e lavate con alcool a fine turno (non sono aneddoti, ma disposizioni e consigli della Direzione, sempre verbali ovviamente). Progressivamente hanno abbassato il livello di guardia, dichiarando che diversi presidi utilizzati all’inizio non erano più necessari. Conta che nei nuovi reparti di terapia intensiva che sono stati inaugurati da noi, le visiere necessarie se le sono comprate i medici: al Brico Center, prendendo quelle da giardinaggio. Mano a mano che si aprono le terapie intensive, quindi, in sostanza i presidi non ci sono.
Questo per quanto riguarda i reparti dedicati ai pazienti covid-positivi. Nel vostro reparto, invece?
Noi siamo obiettivamente quelli più a rischio. Oggi, infatti, come fai a dire con sicurezza che un paziente non è covid-positivo, soprattutto visto e considerato che siamo in Lombardia? Tutti i pazienti dovrebbero essere pensati come potenzialmente positivi nell’ambito di una pandemia, per definizione e secondo rigore scientifico, ma ciò non succede. Il fatto quindi che i sanitari del nostro reparto abbiano minori protezioni rispetto a quelli di altri reparti, mette tutti a rischio. Pazienti compresi.
Ma dall’alto come è stata veicolata questa carenza di presidi, a livello di direttive?
Le direttive sono cambiate progressivamente alleggerendo i presidi. Mentre quindi all’inizio sembrava che fosse necessario avere tutto, poi le necessità sono state ricalibrate sulla base di quel poco che c’era. E il risultato, è sotto gli occhi di tutti.
La carenza dei DPI (dispositivi di protezione individuale) non viene comunque riconosciuta ufficialmente dalla Direzione.
Mi accennavi a una soluzione messa in campo nella gestione dei vostri pazienti…
Sì. Come ti dicevo Regione Lombardia ha fatto in modo di creare una rete oncologica in modo da dirottare una parte dei nostri pazienti su centri chirurgici che potessero essere considerati covid free (almeno sulla carta).
Questa potrebbe essere una soluzione provvisoria concreta?
Solo parzialmente. È una decisione, infatti, che è stata presa in clamoroso ritardo e che avrebbe dovuto essere subito operativa. Poi c’è un altro problema, che questa decisione evidenzia, e che riguarda la commistione tra pubblico e privato. Il nostro è un ospedale pubblico “puro” (che permette al paziente di essere assistito senza dover pagare) dopodiché abbiamo all’interno dell’ospedale la possibilità di fare degli interventi e delle visite private, senza però che questo possa ridurre la capacità della struttura di curare il paziente non pagante. Esistono poi delle strutture private convenzionate e infine i privati puri. Ora, cos’ha fatto Regione Lombardia? Ha organizzato le cose in modo che noi, ospedali pubblici, iniziassimo a lavorare solo per i pazienti covid ma ha lasciato che le strutture private pure o private convenzionate continuassero a lavorare per i fatti loro.
Questo cosa implica?
Implica che un paziente che, puta caso, arriva da me a febbraio per un tumore e viene messo in lista d’attesa, a marzo verrà operato in una di queste strutture. Il tutto a loro beneficio, economicamente parlando. E ti dico di più: mentre qui noi impazziamo per cercare in qualche modo di stare dietro a tutto, nella clinica X o Y c’è ancora chi va a farsi mettere qualche misura in più di reggiseno… con un anestesista, pagato profumatamente dal paziente, che potrebbe essere impiegato negli ospedali pubblici, dove l’urgenza di personale in reparti covid, svuota di anestesisti anche reparti come il nostro. Anche questi non sono, ahimè, aneddoti ma fatti realmente accaduti. Pensa che in questo momento, i colleghi dell’ospedale privato convenzionato in cui andiamo a operare i nostri pazienti, ci hanno accolti a braccia aperte, perché loro – che lavorano con tanti pazienti che vengono da fuori regione – ora come ora hanno le sale operatorie vuote. A queste strutture quindi, non è parso vero di poter guadagnare sul pubblico: peraltro con responsabilità mediche e legali che rimangono a nostro carico.
A proposito di personale mancante, anche in Lombardia è stato aperto un bando per il reperimento di nuove risorse. Da voi sono stati assunti nuovi medici?
Sì, alcuni anestesisti specializzandi al quinto anno sono stati assunti. Si tratta però di persone che in pratica erano già dentro: da affiancamento, ora sono passati in prima linea. Non è stata, quindi, un’aggiunta vera e propria al netto del numero di persone che lavorano in un reparto.
Tenendo conto di tutte le mancanze che sono emerse, cosa è importante che cambi – a emergenza conclusa – perché in futuro una situazione simile venga affrontata in modo diverso?
Ci sono degli aspetti che possono essere migliorati ma di fatto, il grosso del cambiamento deve avvenire a monte. Parlo proprio di regole del gioco e di aspetti che dovevano essere cambiati da molto prima, perché riguardano tutta la sanità pubblica, dove si lavora allo spasimo e non in sicurezza. La cosa più importante, oggi, sarebbe rimpolpare gli organici e dare forza lavoro agli ospedali. Il secondo tasto dolente riguarda il rapporto tra pubblico e privato perché quello che faccio io qui e quello che fa il mio collega in una clinica privata, ha lo stesso valore ma un prezzo diverso e questo costo viene sostenuto dal paziente. Al di là dei presidi mancanti, al di là delle direttive inadeguate, poi, ci deve essere a livello globale un atteggiamento di tutela della nostra professione, che ci permetta (allo stesso tempo) di tutelare anche il paziente. Guardiamoci in faccia: oggi, per l’opinione pubblica, siamo eroi ma domani rischiamo di essere trascinati tutti davanti all’avvocato per aver fatto prendere la polmonite a chissà quanti pazienti! Ieri ho chiamato un paziente per dirgli che si era liberato un posto in sala operatoria e quando lui mi ha chiesto se poteva stare tranquillo, ho dovuto mettermi una mano sulla coscienza e dirgli: “No, ma mettendo le due possibilità sul piatto della bilancia è comunque meglio che lei venga”.
Parlando di possibili scenari nel futuro prossimo, sembra sempre più plausibile l’eventualità di una stabilizzazione del virus da uno stato di guerra a uno stato di guerriglia, con diversi stop and go…
Sì, al momento è l’ipotesi più probabile.
Anche per quanto riguarda l’Italia?
Secondo me in Italia, ci sono due situazioni distinte: quella delle regioni in cui il virus è stato più virulento, come la Lombardia, che quando ripartiranno probabilmente non andranno incontro a grandi ondate successive, in parte perché (per precauzione) modificheranno il loro stile di vita e in parte perché, sinceramente, penso che la maggioranza della popolazione abbia ormai già contratto il virus (il che presuppone che una qualche forma di immunità di gregge, ormai si sia sviluppata). Ci sarà poi la situazione di regioni dove oggi il virus si è sviluppato meno e in cui, quindi, è possibile che le ondate successive siano molto più forti. In quei casi sì, lo stop and go potrebbe essere l’ipotesi più realistica.
Ecco, l’eventualità di questo tipo di scenario – e quindi la sua normalizzazione, anche se in modo differenziato – non potrebbe stimolare la messa a punto di nuove soluzioni a livello gestionale?
Dipende. La situazione in Cina, per più di due mesi, avrebbe dovuto metterci in guardia e spingerci a trovare risposte e soluzioni in anticipo. E invece no: il virus si è diffuso a macchia d’olio, senza che nessuno Stato dimostrasse di aver saputo far tesoro dell’esperienza cinese. Ognuno ha sempre pensato di essere il più forte, il migliore e che non sarebbe stato toccato. La realtà delle cose ha dimostrato il contrario: bisogna essere preparati. L’esercito, in tutte le nazioni, ha dei programmi per la guerra chimica che includono degli stock di risorse intoccabili (riserve di mascherine, farmaci e materiale vario) che progressivamente scadono e vengono sostituite. Questo insieme a piani di evacuazione, ecc. Queste cose esistono, ma sono confinate al mondo dell’esercito. Creare delle procedure di questo tipo, per uno Stato è una decisione difficile da prendere ma credo che ormai vada considerata seriamente.